12/02/2018
Antieconomicità come presunzione
 Il fatto che l’inerenza risulti una vicenda essenzialmente di tipo qualitativo riverbera una serie di importanti effetti sulle rettifiche fondate sulla cosiddetta “antieconomicità”.
Il fatto che l’inerenza risulti una vicenda essenzialmente di tipo qualitativo riverbera una serie di importanti effetti sulle rettifiche fondate sulla cosiddetta “antieconomicità”. Si tratta di quelle rettifiche da parte dell’amministrazione finanziaria che involgono la sindacabilità dell’entità di una determinata spesa (tipico esempio è dato dai compensi degli amministratori) e che in passato sono state definite di «inerenza quantitativa».
Si è sempre sostenuto che l’inerenza, essendo un giudizio preventivo circa il collegamento tra un componente economico e l’attività esercitata, risulta “per natura”, invece, una vicenda essenzialmente di tipo “qualitativo”. Ed è stato sottolineato che il giudizio di inerenza non risponde all’esigenza di verificare se il contribuente si è comportato correttamente sotto il profilo economico, ma rappresenta quella necessaria “ricognizione preventiva” – quindi quel collegamento – dei componenti economici che hanno un legame con l’attività.
Sicché la negazione di questo collegamento deve realizzarsi entro le regole potestative in tema di accertamento dell’amministrazione finanziaria.
In sostanza, se l’ufficio dell’amministrazione non ammette la deduzione di una spesa, ritenendola non inerente, l’ufficio nega, di fatto, ogni collegamento della spesa con l’attività svolta dall’imprenditore. Con la conseguenza che, in questo caso, si tratta di una rettifica di tipo analitico, per cui l’ufficio deve provvedere a motivare il difetto di inerenza in conseguenza della mancanza di un collegamento della spesa con l’attività svolta da parte dell’imprenditore.
Deve quindi essere chiaro che una rettifica analitica, negandosi ogni relazione con l’articolo 109, comma 5, del Tuir, non può riguardare, come afferma finalmente la Cassazione con l’ordinanza 450/2018, la “congruità” della spesa o del costo, ma deve disconoscere alla radice il legame con la logica economica imprenditoriale.
Questa conclusione permette di spendere due parole sul concetto di prova dell’inerenza. La prova riguarda i fatti, mentre l’inerenza è riconducibile ad una valutazione del fatto o dei fatti. In sostanza, l’ufficio deve valutare se il componente economico – la spesa o il costo – ha un collegamento funzionale con l’attività imprenditoriale.
Quindi, per l’inerenza risulta improprio attribuire alle parti degli oneri di prova. Le parti invece hanno, più propriamente, un onere di allegazione dei fatti posti a fondamento delle proprie tesi. L’ufficio dell’amministrazione deve quindi allegare i fatti e motivare le ragioni per le quali ritiene che determinati componenti economici non hanno alcun collegamento con l’attività, mentre il contribuente, da parte sua, dovrà allegare i fatti e le ragioni per le quali ritiene che gli stessi componenti hanno un legame con l’attività.
Se, invece, l’ufficio vuole rettificare la congruità della spesa, quindi operare su un piano quantitativo, si è senz’altro nell’ambito delle rettifiche di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973, le quali si basano su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. In questo caso, l’onere probatorio ricade, per primo, sull’ufficio dell’amministrazione finanziaria, il quale dovrà dimostrare in giudizio che gli elementi presuntivi fondanti la rettifica hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza. Solo dopo che l’ufficio avrà assolto tale onere, quest’ultimo graverà sul contribuente.
Dario Deotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA


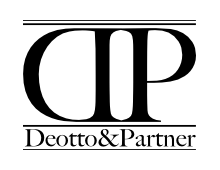
 © 2024 Deotto & Partner,
© 2024 Deotto & Partner,