30/11/2020
Difesa sempre più in salita dalle presunzioni pro Fisco

Nel diritto tributario italiano si stanno registrando delle preoccupanti manipolazioni delle regole sull’onere della prova. Risultano infatti attribuiti impropriamente al contribuente degli oneri probatori che non gli spettano, oltreché totalmente illogici e impossibili da assolvere. È il caso della recente ordinanza 25501/2020 della Cassazione, con cui è stato stabilito che il socio di società a ristretta base partecipativa è chiamato a fornire la prova contraria anche in ragione dei costi ritenuti indeducibili per la società. Il contribuente «resiste» La ripartizione dell’onere della prova nel rapporto tributario segue le regole dall’articolo 2697 del Codice civile («chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»). Questo significa che l’Agenzia è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. In pratica, affermando l’esistenza dell’obbligazione tributaria, con l’emanazione dell’atto di accertamento, l’amministrazione assume la posizione di creditore nei confronti del contribuente, con la conseguenza che riveste in sede giudiziale il ruolo di attore in senso sostanziale, sul quale grava l’onere di provare la fondatezza della propria pretesa. Se l’amministrazione assolve il proprio onere, il contribuente ha la possibilità di difendersi muovendosi nell’ambito dello stesso thema probandum delineato dalla controparte, oppure allegando in giudizio fatti diversi – quindi impeditivi, modificativi, estintivi – che avrà l’onere di provare. In sostanza, il fatto che il contribuente proponga ricorso contro l’atto dell’Agenzia è dovuto essenzialmente a evitare che lo stesso atto divenga definitivo. Nel processo tributario il contribuente formalmente agisce, ma in realtà resiste: promuovere l’azione non può tradursi nell’onere di dover provare i fatti costitutivi di una pretesa che non è la propria. Quando l’onere è invertito In presenza di prova presuntiva, il principio secondo cui l’onere di prova grava, in prima battuta, sull’amministrazione risulta sovvertito solo se ci sono presunzioni legali relative, le quali attribuiscono l’onere di prova al contribuente. Illustre dottrina (Allorio) ha acutamente affermato che la presenza di presunzioni legali nella fiscalità non fa altro che confermare indirettamente il principio che l’onere di prova grava, come regola, sugli uffici. Il fatto è che molte volte si leggono pronunce nelle quali l’onere della prova – ad esempio, sulla deducibilità dei costi nel reddito d’impresa – spetta al contribuente. Nulla di più errato: il reddito d’impresa va assunto nella sua unitarietà, così che i costi concorrono insieme ai ricavi a integrare la fattispecie imponibile. La possibilità di dedurre i componenti negativi di reddito non rappresenta, in sostanza, una norma di favore, per cui anche per i costi devono valere le regole sopra indicate. Una vera e propria manipolazione del criterio di ripartizione dell’onere di prova si registra poi con le presunzioni cosiddette “giurisprudenziali”. Per effetto del consolidato orientamento della Cassazione, quelle che, in realtà, rappresentano delle presunzioni semplici (con onere di prova che compete in primo luogo sull’Agenzia) si trasformano – pur non essendolo – in presunzioni legali relative. Così è il contribuente a dovere fornire la prova contraria. Quest’ultima però – come nel caso dei soci delle società a ristretta base partecipativa – si trasforma spesso in un onere di prova negativo: il fatto di non avere percepito l’utile. Si tratta di una probatio diabolica: il socio quasi sempre non ha strumenti per dimostrare di non averlo percepito. Le gravi conseguenze La questione certamente si aggrava se – come stabilito dalla pronuncia della Cassazione 25501/2020 – tale presunzione, già alterata, viene estesa anche ai costi ritenuti indeducibili per la società. Si noti che l’ordinanza della Corte equipara i costi indeducibili in genere – come possono esserlo, ad esempio, i maggiori ammortamenti – ai ricavi in nero. Si tratta di un grave precipitato, che trascura che è provabile soltanto ciò che è (almeno) probabile. La “distribuzione di costi indeducibili ai soci” non solo non è probabile, ma rappresenta una violazione dei più elementari canoni di ragionevolezza. Senza contare che si tratta di vicenda illegittima, perché quando il Fisco attribuisce il maggior reddito della società ai soci, senza scomputare – come fa quasi sempre – le maggiori imposte accertate alla stessa società a ristretta base, disattende le specifiche norme (articoli 5 e 116 del Tuir) che stabiliscono l’attribuzione ai soci di un reddito d’impresa per trasparenza solo nei casi tassativi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Luigi Lovecchio


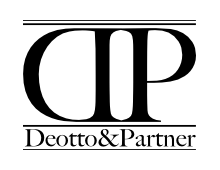
 © 2024 Deotto & Partner,
© 2024 Deotto & Partner,